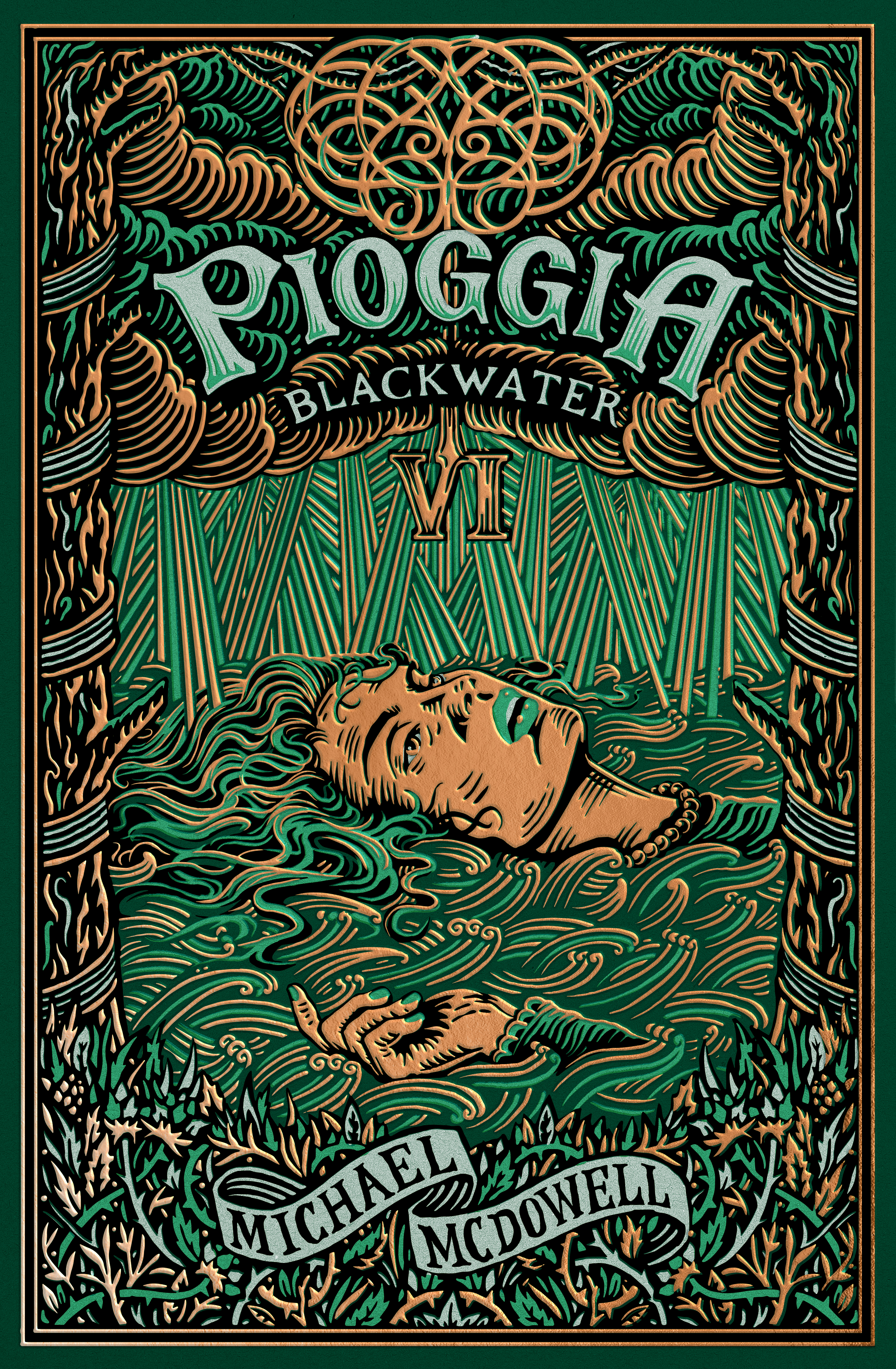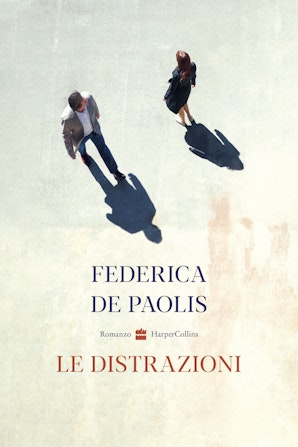Collana:
Numero collana: 499
Pagine: 196 - Prezzo cartaceo: € 16
Data pubblicazione: 24-02-2022
Il libro
È un pomeriggio di primavera quando, con
lo stesso corpo e la stessa età del giorno della propria morte, Diego
Valli risorge. Si risveglia sul pianerottolo di quello che era stato il
suo appartamento, tira fuori le chiavi, prova a infilarle nella
serratura ma si trova faccia a faccia con il figlio Oscar, lasciato
bambino e invecchiato ormai di oltre quarant’anni. Da qui, ha inizio una
vicenda di riconciliazioni e distacchi, una storia intensa e sincera
sul rapporto tra padri e figli e sulla necessità del perdono.
Una volta riconosciuto il padre, Oscar affronta il comprensibile
straniamento aggrappandosi alle incombenze della quotidianità, mentre
Clara, sua moglie, non crede al miracolo e si oppone all’idea di
ospitare in casa uno sconosciuto. A complicare le cose, si aggiunge
l’arrivo di Gaia, la figlia della coppia, che torna nella città natale
per trascorrere le vacanze. Di nascosto dalla madre, che è spesso via
per lavoro, Gaia finalmente ha l’occasione di conoscere suo nonno: un
uomo profondo, amante della musica, più simile a lei di quanto sia mai
stato suo padre. Oscar, al contrario, scoprirà aspetti di Diego che non
pensava gli appartenessero.
Dopo il perturbante e vertiginoso Blu, Giorgia Tribuiani torna
con un romanzo dalla prosa tesa e accattivante che si appunta su una
storia a tre voci di rabbia e dolore, parole non dette e seconde
occasioni. Una riflessione sulla famiglia dalla trama originale in
bilico tra realtà e impossibile per un’autrice che, come poche, sa
scavare nell’animo umano per far emergere il rimosso e stimolare la
comprensione con uno stile personale notevole e a tratti sorprendente.
«Padri testimonia come
in minime storie possono rivelarsi spazi immensi. Un libro d’amore in
senso largo, come accettazione e accoglienza dell’altro, quindi
comprensione dell’umano al di là del proprio perimetro individuale.
Certo c’è anche di più: la voce del perdono, la generosità di offrire
sempre altre occasioni di fronte alla mancanza, all’assenza, ai sempre
possibili errori che accompagnano i giorni che ci sono dati. Alla fine,
verrebbe solo da dire, da parte di chi scrive come di chi legge: non è
niente, è la vita soltanto».
Remo Rapino
RECENSIONE
Dopo aver narrato di arte e ricerca di sé nelle precedenti opere Guasti e Blu, Giorgia Tribuiani torna a scavare l’animo umano con un tema più tradizionale, quello dei rapporti familiari, nell’ultimo romanzo Padri, edito da Fazi, trovando anche questa volta una chiave narrativa originale. Dialoghiamo con l’autrice.
Padri mi ha ricordato lo schema dei romanzi di Saramago, che poi andando più indietro è lo stesso della Metamorfosi
di Kafka: accade un fatto iniziale inspiegabile e poi il resto è tutto
perfettamente logico e conseguente. In questo caso il fatto onirico
scatenante è la resurrezione di Diego Valli, padre di Oscar, nonno di
Gaia. Dalla Lettera al padre di Kafka è anche tratta la frase in esergo, è quindi lui il “padre” letterario di questo romanzo? E ce ne sono altri?
Kafka è sicuramente il principale modello di riferimento: in primis,
come giustamente osservi, proprio per la struttura della narrazione.
Come fa notare Tvetan Todorov nel suo illuminante La letteratura fantastica,
prima di Kafka la caratteristica principale dei racconti del fantastico
era il movimento progressivo dal reale all’irreale: a un certo punto,
in un mondo perfettamente conosciuto, si apriva una crepa, uno squarcio,
e questo strappo andava via via allargandosi lasciando prima
intravedere e poi penetrare avvenimenti non spiegabili secondo le leggi
di quel mondo; il personaggio – e quindi il lettore – si trovava in una
condizione di “esitazione” dove il nocciolo di tutto, mentre il
fantastico esplodeva nella realtà passando dalle poche tracce a una
presenza ben evidente e sostanziale, diventava capire se l’evento
surreale fosse conseguenza di una distorsione dei sensi (dovuta al
sonno, alla pazzia, a sostanze psicotrope) o di leggi fino a quel
momento ignorate. Con Kafka tutto questo cambia. Il fantastico, per
esempio nel racconto La metamorfosi, irrompe nel reale con la
sua piena potenza, spalancando la porta ed entrando tutto in una volta, e
poi resta lì, di fronte a personaggi che più che esitare devono lottare
per “adattarsi” nella quotidianità alle nuove condizioni. In questo
senso Kafka è assolutamente il padre letterario di questo romanzo: come
ne La metamorfosi, la crepa nel reale si apre una volta sola anche in Padri,
all’inizio, e tutta la storia non è altro che una reazione e un
adattamento del reale a questo squarcio; una catena di rapporti di
causa-effetto, il crollo delle tessere verticali di un domino dopo la
schicchera iniziale. Oltre a Kafka confermo poi anche le influenze da
parte di Saramago, oltre che di Dostoevskij (in particolare con I fratelli Karamazov),
di Lem e, cambiando totalmente tipologia di romanzi, di Pamela Lyndon
Travers: anche nel ciclo di romanzi su Mary Poppins, infatti, l’arrivo
del personaggio magico che dà il via alle vicende (e, in questo caso,
anche il titolo ai libri) non fa del personaggio stesso la protagonista:
protagonista è la famiglia Banks, che cambia, che si evolve nelle sue
relazioni e nelle sue epifanie, che disegna – per dirla in termini
“tecnici” – degli archi narrativi.
L’elemento soprannaturale del ritorno del padre defunto
diventa pretesto per indagare il tema classico dei rapporti familiari. I
membri della famiglia Valli non vivono grandi tragedie, eppure sono
infelici. Applicheresti ai tuoi personaggi la famosa frase di Tolstoj «Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo»? E cosa in particolare rende infelice questa famiglia?
La frase di Tolstoj mi sembra appropriata. Aggiungo che, a mio
avviso, anche ogni membro di questo tipo di famiglie ha un modo tutto
suo di essere infelice: nel caso di Oscar, Clara e Gaia, che non fanno
eccezione, il primo lo fa rifugiandosi nelle certezze, nella
razionalità, nelle cose che conosce (è un chimico, e come canta De
André: «da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e
farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si
combinassero attraverso l’amore, affidando ad un gioco la gioia e il
dolore»); la seconda alzando un muro, arroccandosi nella propria
posizione con le proprie certezze; la terza, viceversa, provando ad
agire fino a restare quasi senza forze. Ciò che dunque rende infelice
questa famiglia, per rispondere alla tua domanda, è principalmente
l’incapacità di ascolto. Una famiglia dovrebbe essere composta non solo
dai suoi membri ma anche dalle loro relazioni (sono in fondo proprio le
relazioni a definirci come padri, madri, figli e figlie, sorelle,
fratelli): in quest’ottica la famiglia Valli sembra piuttosto un trio di
monadi, di personaggi che disperatamente vorrebbero essere ascoltati,
ma che non trovano a loro volta la forza di ascoltare: lo capirà ed
esprimerà senza censure il nonno risorto quando, parlando con Oscar a
proposito di Gaia, affermerà che «non ci sono vincitori, tra voi due; tu
nemmeno la ascolti, la sua ultima parola, e lei non ascolta le tue […]
Quello che voglio dire è che ci fate poco, con le ultime parole, se non
ascoltate quelle prima»). Del resto la famiglia Valli non è così brava
neppure a comunicare, a parlare: il precario equilibrio in cui si trova
al momento dell’arrivo del nonno è destinato a infrangersi perché
costruito sui “non detti”, su conversazioni sempre superficiali a fronte
di movimenti emotivi profondissimi: mostrare questo iceberg è stata una
delle mie principali preoccupazioni dal punto di vista stilistico;
l’uso abbondante del monologo interiore mi è servito per mostrare quanto
ognuno dei tre protagonisti avesse da dire e quanto poco di questo
riuscisse poi ad affiorare nel dialogo.
Diego risorge con le stesse fattezze, gli stessi abiti e
stessa età del giorno della sua morte. È così che immagini la
resurrezione dei corpi? Nemmeno la Chiesa è mai stata chiara al
riguardo. Il ritorno di Diego ha per te anche una connotazione religiosa
o è solo un espediente letterario per dire altro?
Uno dei principali stimoli all’invenzione di questo romanzo (o almeno
della sua prima scena) fu proprio una serie di domande a riguardo che
Tiziano Terzani poneva alla Chiesa in uno dei suoi libri: accettata
l’idea della resurrezione dei corpi, in quale stadio del nostro corpo è
possibile immaginare un nostro ritorno? un uomo mutilato di un braccio è
destinato a risorgere con o senza il braccio? l’anziano è destinato a
risorgere nella sua “ultima” età o in una precedente, che pure gli è
appartenuta? Ricordo che quest’ultima domanda mi colpì, generando subito
in me una piccola ossessione e – di conseguenza – la prima scena del
romanzo, o meglio il fotogramma in cui l’ultracinquantenne Oscar apre la
porta di casa e si trova di fronte il padre più giovane, perché risorto
nel corpo lasciato al momento della morte (un corpo di ventottenne
nelle prime stesure; un corpo di quarantenne nella versione definitiva
nel romanzo). In questo senso la mia immaginazione non è una risposta
alla domanda, ma la concretizzazione narrativa di una possibilità.
Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, per me il
ritorno di Diego non ha una connotazione religiosa, o almeno non in
senso stretto. Al di là delle domande che mi hanno portata a immaginare
l’incipit, al di là dell’utilità, come giustamente rilevi,
dell’espediente letterario, ha trovato strada nel romanzo una
riflessione sul “senso del sacro”, sulla “spiritualità”. In questo senso
mi è stato di ispirazione Teorema di Pier Paolo Pasolini:
Clara, per esempio, così come la famiglia borghese del romanzo
pasoliniano, è talmente arroccata nelle proprie paure e nelle proprie
credenze da non saper accogliere l’evento miracoloso in tutta la sua
portata; non è in grado di compiere quell’atto di fede (che
presupporrebbe prima di tutto un atto di fiducia nei confronti del
marito) necessario a colmare la distanza tra la risposta razionale
all’arrivo di Diego e l’accettazione che Oscar possa sentirsi legato a
quest’ultimo su un piano spirituale.
Tema ricorrente dei tuoi tre romanzi, Guasti, Blu e Padri,
è il desiderio di essere visti, guardati, apprezzati. Le protagoniste,
Giada, Ginevra e Gaia, con cui condividi l’iniziale del nome, cercano
nello sguardo altrui la propria identità. Cosa significa per te, come
persona, essere guardata, e come scrittrice coincide con l’essere letta?
Per quanto mi riguarda penso di essere molto simile alla mia Blu:
cerco costantemente di nascondere agli occhi altrui le mie paure, le mie
fragilità, i miei pensieri “sbagliati” (sono ossessionata dall’immagine
che gli altri possono avere di me, da quello che possono pensare – a
niente è valso cercare di interiorizzare la frase di David Foster
Wallace che tanto amo: «La vostra preoccupazione per ciò che gli altri
pensano di voi scompare una volta che capite quanto di rado pensano a
voi»); al tempo stesso, però, desidero che gli altri mi comprendano al
cento per cento, che mi apprezzino e amino “a prescindere da” (o a volte
“anche per”) quelle stesse paure, quelle stesse fragilità, quegli
stessi pensieri sbagliati.
Tante volte, scrivendo Blu, avrei voluto dire alla mia
protagonista: ma come pensi che possano apprezzarti a tutto tondo se non
dai loro la possibilità di conoscerti a tutto tondo? In questo senso
Blu mi ha fatto da specchio, così come mi rivedo in lei nel mio
approccio all’arte: quello della scrittura è l’unico spazio dove
qualsiasi paura scompare, dove riesco a non autocensurarmi, dove sono
molto d’accordo con la frase di Giulio Mozzi che recita «la parte di te
che scrive non ha bisogno dell’approvazione delle altre parti di te».
Tutti i miei romanzi hanno una sincerità violenta che non mi concedo
nella vita di tutti i giorni se non con pochissime persone care. La sola
idea di parlare in quel modo con tutti gli sconosciuti che mi leggono
mi farebbe girare la testa. In questo senso, considerato che nella
scrittura riesco a parlare davvero e a non nascondermi, essere letta mi
dà una possibilità in più per essere guardata: certo, poi non dipende
tutto dall’oggetto ma anche dal soggetto (con, in questo caso, la sua
sensibilità più o meno vicina alla mia), e dalla relazione che si
instaura tra i due.
In Padri viene ribaltato il luogo comune che vuole
il padre razionale e la madre istintiva ed empatica. Infatti, mentre
Oscar è subito disposto a credere di avere di fronte il proprio padre
redivivo, Clara, sua moglie, porta avanti fino alla fine del romanzo una
posizione diffidente e scettica, quando non apertamente ostile. Nella
società attuale in effetti i ruoli paterno e materno sono in effetti in
trasformazione rispetto alla visione tradizionale. È voluto questo
ribaltamento di genere? E cosa rappresentano i due diversi punti di
vista dei genitori di Gaia?
Il ribaltamento in questo caso è stato la conseguenza di una scelta:
quella di proporre una corrispondenza tra i due padri; di dare a Oscar,
che rappresenta la generazione di mezzo e l’anello di congiunzione tra
Diego e Gaia, uno “specchio”. Questa scelta di base sulla discendenza
paterna ha determinato a cascata un maggiore atto di fede/fiducia da
parte di Oscar, una spinta maggiore a “credere”. Probabilmente questo
tipo di approccio che prevede l’inquadramento della relazione prima di
quello del personaggio (un approccio che si abbina bene a un vecchio
mantra dello scrittore Giulio Mozzi: «non esistono i personaggi,
esistono le loro relazioni», ma anche al nuovo modo di intendere il
teatro per cui l’attore è prima di tutto un re-attore), deriva molto
dalla mia visione “liquida” dei caratteri. Oscar è di fatto un
personaggio razionale, cosa che la figlia gli rimprovera da anni, ma di
fronte alle nuove circostanze è costretto a cambiare, a cedere a quello
che “sente”, a rinnegare almeno in parte le proprie certezze. Questo è
del resto uno dei motivi per cui amo molto le storie soprannaturali e
horror: i personaggi fanno esperienze limite e, per non soccombere, sono
costretti a mutare, ad abdicare in favore di altri sé. Fanno e pensano
cose che mai avrebbero pensato, sono disposti a tutto, esplorano le
proprie potenzialità come mai avrebbero fatto. In questo senso i due
punti di vista sono due possibili reazioni “chimiche”: dati due
personaggi diversi con due bagagli esperienziali diversi e due reti di
relazioni diverse, lo stesso evento ha effetti – va da sé – diversi.
Clara è colei che resta ferma, non fa neppure un passo, e perde il
contatto con il resto della famiglia; Oscar, aiutato dal proprio bisogno
di recuperare il padre, evolve.
A volte le azioni più affettuose non vivono di slanci, ma
di mite e ostinata costrizione, Come quei ti voglio bene che la bocca
deve sforzarsi a dire. Quel rendere orgogliosi. Successi inaspettati di
qualcuno che hai vicino e che hai paura non ti veda come prima. Domata
gelosia.” Sicuramente tema portante del romanzo è
la difficoltà di comunicazione all’interno dei rapporti familiari, la
rabbia, i silenzi, il non detto, l’incapacità di esprimere i propri
sentimenti. L’assecondare desideri e aspettative altrui per guadagnarsi
l’amore, che – piaccia o meno – non è mai davvero incondizionato. Quanto
è giusto secondo te fare questo sacrificio, e quando invece diventa
rinuncia a sé stessi?
Questa è una domanda da un milione di dollari. Non credo ci sia una
risposta valida per tutti, e ho il sospetto che questa risposta finisca
per variare anche per una stessa persona: in base alla fase della vita
che sta attraversando, in base al bisogno «d’attenzione e d’amore» di
quello specifico momento eccetera. In senso stretto ogni forzatura, ogni
costrizione è una – seppure infinitesimale, in certi casi – rinuncia di
volontà o di spontaneità, a prescindere dalla bontà del risultato. Alla
domanda da un milione di dollari posso dunque dare una risposta che
apparirà banale: per me, per come la vedo io, conviene cercare di capire
cosa rischieremmo di perdere non forzandoci e cosa (di noi, in primis)
facendolo, e mettere i due esiti sulla bilancia.
Un altro tema portante, strettamente legato al primo, è la
seconda occasione, quella che tutti sogniamo: poter tornare indietro a
riparare gli errori, nei sentimenti, nel lavoro, nelle decisioni in
generale. Ma al termine del libro mi è rimasta una domanda: anche avendo
la possibilità di viverle, le seconde occasioni sono risolutive o si
finisce per commettere di nuovo gli stessi errori?
L’occasione è uno strumento: riuscire a coglierla davvero, e quindi a
non ripetere gli stessi errori, è dunque qualcosa che a mio avviso non
dipende dall’occasione, ma dall’avere capito – appunto – di avere
commesso degli errori. Dall’avere imparato a usarlo, questo strumento, o
dall’essere pronti a tentarne un utilizzo diverso. Perché si possa
reagire in modo differente di fronte a uno stimolo simile è necessario
(ma comunque non per questo sufficiente) che le consapevolezze siano
mutate, maturate; che ci sia stata la volontà di un esito diverso, o
quantomeno il suo germoglio: dipende da noi; viceversa la seconda
occasione potremmo non vederla neppure.
Il padre di Gaia ha una visione competitiva e meritocratica
della vita, tanto che la spinge ad essere sempre la migliore, ad esempio
negli studi, subordinando ai risultati anche l’affetto, o almeno la sua
espressione. È un atteggiamento piuttosto diffuso da parte dei
genitori, che di solito lo giustificano con lo scopo di spingere i figli
a dare il meglio, per il loro bene. Non sarà invece piuttosto una
proiezione sui figli del proprio ego?
Spesso i genitori tendono a vedere i figli come proprie estensioni,
come propaggini: si sentono responsabili dei loro errori e parte dei
loro successi. Non dico che questo non possa essere vissuto in modo
sano. Il genitore è in fondo il primo educatore. Le cose cominciano a
diventare problematiche, tuttavia, quando l’invito a eccellere, o ad
appassionarsi a una certa disciplina (penso alle storie di tutti i figli
che, a lungo, hanno suonato uno strumento o praticato uno sport, magari
anche agonistico, solo per “compiacere” il genitore, o a quelli che
hanno rinunciato ai propri desideri per ereditare il lavoro del padre o
della madre), non hanno più a che fare con il figlio, ma con il
genitore. Con le sue passioni o – in alcuni casi – con le sue
frustrazioni. “Non sono riuscito a diventare nessuno, ma adesso mio
figlio…”.
Penso che, come in tutte le cose, il segreto sia nella misura e nella
consapevolezza, nella capacità di distinguere le spinte altruistiche da
quelle egoistiche (non dico sia facile: a volte, e questo non riguarda
solo il rapporto tra i genitori e i figli, non sappiamo accettare per
esempio che un talento venga sprecato a fronte di un mancato interesse
nel coltivarlo, o che una persona che sappiamo caparbia si abbatta –
specie se la amiamo) e nella cura con cui si usano le parole: nel mio
romanzo Gaia sente di dover “meritare” l’amore di suo padre («è come se
il suo affetto – confida al nonno – dovesse passare per l’orgoglio. Che
quando disapprova con lo sguardo ti pare che tutta la Terra disapprovi;
che tutto l’affetto della Terra potevi meritarlo e non l’hai fatto»). Di
fronte a una situazione di questo tipo un figlio può sentirsi sotto
ricatto morale, mentre al contrario dovrebbe sempre potersi sentire
sicuro del bene del proprio padre; dovrebbe poterlo sapere svincolato
dalle proprie prestazioni.
Ad un certo punto mi sono chiesta, ma il padre, non lo
dovevamo uccidere? Perché invece continua a risorgere? Gaia,
universitaria ormai prossima alla laurea, si preoccupa più di tutto dei
rapporti tra suo padre e sua madre, tra suo padre e suo nonno, invece di
costruire rapporti propri, con gli amici, con un nuovo amore. Giovane
ma già vicina all’indipendenza, perché continua a guardare al passato,
invece di lanciarsi nel futuro? Si dice che in Italia troviamo
particolare difficoltà a staccarci dalla famiglia d’origine, a livello
sia economico e sociale che psicologico, credi che sia vero?
Non saprei: da un lato al giorno d’oggi i figli tendono a restare con
le famiglie d’origine fino a un’età molto più avanzata rispetto al
passato, o a dipendere economicamente da queste; dall’altro è vero anche
che oggi ci sono figli che non possono contare come un tempo sulle case
di proprietà (che spesso in passato erano limitrofe a quelle dei
genitori, o magari erano appartamenti al piano di sopra o di sotto),
figli che lasciano il “nido famigliare” a diciotto anni, figli che si
spostano all’estero per avere più opportunità lavorative. C’è una
complessità tale che rende – almeno a me, che sono una profana in
materia – molto difficile l’interpretazione. Differente è secondo me il
discorso psicologico. Oggi i figli possono “parlare” con i propri
genitori, osservare le loro problematiche, vederli divorziare,
innamorarsi, soffrire, piangere, sfogarsi: la distanza relazionale di un
tempo è quasi azzerata (ricordo che mia nonna disse una volta che ai
suoi tempi dava “del voi” alla madre, e certamente non c’era spazio per
le confidenze reciproche) e credo che per certi versi sia naturale
preoccuparsi di più per genitori che ci appaiono più umani, della cui
felicità a volte finiamo per sentirci addirittura responsabili (è poi
uno dei temi di Blu, il mio secondo romanzo, dove la
protagonista si “investe” di un ruolo che la obbliga a rendere sempre
felice la madre, pena un forte senso di colpa e di inadeguatezza).
Mi ha colpito il personaggio di Diego, il nonno, che si
ritrova in un mondo diverso da quello che conosceva, più complesso, più
tecnologico, in cui l’amata moglie non c’è più e gli amici sono morti o
invecchiati al punto da non riconoscerlo. A una lettura superficiale
Diego può apparire come puro strumento per la crisi e la crescita degli
altri personaggi, ma in realtà la sua dimensione personale è la più
tragica. “È che il tempo della morte è un tempo crudele, non
conserva il nostro posto: è come quando giochi a beach volley, no?, che
se esci, se vai a prendere un gelato, non è che poi rientri quando ti
pare; non è che prendi e fai lo schiacciatore mentre in campo c’è altra
gente” scrivi verso la fine. Anche lui ha una seconda occasione, ma
saprà coglierla? Cosa rappresenta Diego in sé stesso, al di là degli
effetti del suo strano ritorno?
Diego, per me, è proprio colui che la seconda occasione non può
coglierla, o almeno, sicuramente, non fino in fondo. Se è vero quanto ho
scritto prima, e cioè che l’occasione è solo uno strumento e che siamo
noi – è il nostro modo di essere e di approcciarla con tutta la
consapevolezza che abbiamo degli errori commessi e delle cose che
vorremmo cambiare – a fare la differenza, se questo è vero, il povero
Diego, che si trova proiettato in un battito di ciglia da un tempo
all’altro, da una vita all’altra, da una rete di relazioni all’altra,
manca di tutto un percorso, non ha materialmente la possibilità di
accogliere il miracolo che gli viene donato, e che di fatto,
comprensibilmente, lui non riconosce come tale. «Non ci sono
possibilità, per me; non più. Non sono parte di niente. Questo non è il
mio tempo. Questo non è il mio miracolo.», affermerà verso la fine, e
avrà ragione: quello che lui sta vivendo è il miracolo di Oscar, di un
uomo che ha avuto tutto il tempo di cambiare e di interiorizzare il
passato prima di trovarsi di nuovo faccia a faccia con il proprio padre e
con le proprie ombre.
Ho trovato tra le righe un’attrazione appena accennata tra
Diego, il nonno rimasto quarantenne, e la nipote Gaia. Lui rivede in lei
la moglie quando era giovane, lei trova in lui una figura più sensibile
e affine rispetto al suo vero padre. Hai mai pensato a una linea
narrativa in cui tra i due nascesse una storia d’amore, che si potrebbe
definire ultra-edipica? O questa traccia l’ho vista solo io, perché mi
piace pescare nel torbido?
Sei una lettrice incredibilmente attenta! In una precedente stesura
il nonno risorgeva un po’ più giovane (ventotto anni, come scrivevo
rispondendo a una tua domanda precedente) e Gaia era al contrario un po’
più grande (venticinque) e tra i due si creava una particolare
attrazione. Questo improvviso riconoscersi di Gaia nel nonno – uno
spirito poetico e romantico e amante dell’arte come lei – danzava sul
confine tra affetto famigliare e sensazione di aver trovato “l’uomo
giusto”: il significato della storia si spostava un po’; suonava come:
«tutti noi vogliamo essere amati dalla nostra famiglia e alla fine
creiamo da zero una famiglia che ci ami». Aveva un suo senso, ma al
tempo stesso si discostava troppo da quello che volevo raccontare: il
tentativo da parte di Gaia di “sostituire” il padre, seguito dalla
consapevolezza di avere messo a confronto un genitore con tutti i suoi
difetti (Oscar) con un uomo idealizzato (Diego). Insomma: mi interessava
rimanere sul tema della paternità e della sua percezione, senza
rischiare che il lettore concentrasse la sua attenzione su altro. Così
ho invecchiato Diego e ringiovanito Gaia, in modo che la distanza di età
tra i due potesse generare più un rapporto padre-figlia che uno
amoroso. Si vede che un po’ della tensione che avevo infuso nelle scene
tra i due deve essere rimasta palpabile, per un occhio attento.
C’è chi dice che si scrive per tutta la vita lo stesso libro,
e c’è chi effettivamente lo fa, invece tu ci hai già dato tre romanzi
molto diversi, sia per quanto riguarda i temi che lo stile, a questo
punto siamo curiosi del prossimo, che cosa stai preparando?
Per tematiche e costruzione, il prossimo romanzo sarà sicuramente il
più lontano da tutti gli altri: ho appena terminato la prima stesura di
una storia corale dove, in un villaggio immaginario le cui comunicazioni
sono in mano a merli grandi come bambini, tutti gli abitanti vengono
chiamati a partecipare a uno strano macabro gioco, con tanto di
regolamento, penalità e premio per i vincitori.
A narrare la storia, questa sorta di favola nera, è una voce che
cerca di ricostruire i fatti raccogliendo lettere, pagine di diario,
appunti e altri documenti che sono presenti a loro volta nel testo, come
inserti.
Mi sono divertita moltissimo.